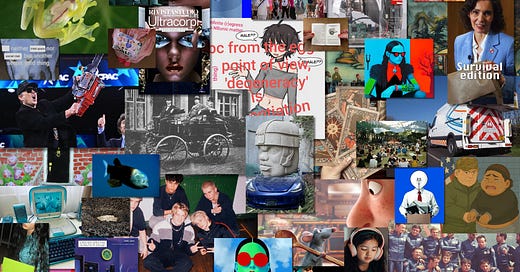Anche tu sei cronicamente online? #38
Messaggio audio + Segnali da → Italian brainrot, accelerazionismo, corpi digitali, fumatori, tenerezza, regressive nostalgia, scale di grigio, quarti luoghi, cartomanti, comunità musicali.
Introduzione
Anche per questo numero abbiamo voluto continuare l’esperimento (grazie per i commenti positivi!) della rassegna stampa audio: una guida alla lettura e un commento sui contenuti con Ilaria Nicoletta Brambilla, curatrice di questo numero, e Stefano Daelli.
→ a cura di Ilaria Nicoletta Brambilla
Immagina di raccontare un episodio accaduto qualche anno fa, accompagnandolo con dei gesti (d’altronde). Come indichi quel tempo passato? Probabilmente avrai condotto la mano verso di te, vicino all’orecchio, portando l’interlocutore in un punto imprecisato oltre la tua spalla. E se invece vuoi dire che ci vediamo dopo? La stessa mano si muoverà con una rotazione in avanti, a indicare l’accelerazione verso un momento che ancora deve arrivare, un punto nello spazio-tempo che raggiungeremo dopo aver svolto un percorso, ideale e reale.
Nonostante la creatività motoria italiana, non siamo i soli al mondo a gesticolare, né a considerare la cognizione del tempo (quando centrata sulla persona) associando il passato alle nostre spalle e il futuro davanti a noi. Tuttavia, ci sono alcune culture, come quella della popolazione andina Aymara, che usano gesti simili ed espressioni per indicare l’opposto, cioè il passato davanti alla persona e il futuro alle spalle. Questo per varie ragioni, tra cui l’idea che il passato è qualcosa che si conosce, si può vedere con gli occhi dell’esperienza e del ricordo, mentre il futuro è un mistero e ne sappiamo tanto quanto qualcuno che cammina all’indietro.
I Segnali di questo mese continuano a raccontare lo scenario culturale in cui siamo immersɜ come una frammentazione di nicchie, tendenze, esperimenti che forse non hanno nemmeno la velleità di durare nel tempo. La politica diviene distopica immergendosi nell’assurdo, i corpi si dissolvono nel loro stesso controllo, andiamo a rifugiarci in un passato che appare più stabile e a ricercare l’intimità in piccole cerchie on e offline, mentre la morte - come grande rimosso dell’Occidente - insiste perché ci occupiamo più concretamente di tutto ciò che finisce. Tentare di afferrare questi Segnali dà l’impressione di inseguire coriandoli in un tornado e, spesso, anche noi ci sentiamo disintegratɜ.
Gli Aymara non hanno tutti i torti, il futuro è davvero fuori dal nostro campo visivo. E se è innegabile che la forma del nostro presente ci generi ansia per ciò che ci aspetta più in là nel cammino, qui facciamo affidamento sulla visione periferica e proviamo a riflettere insieme da che parte vogliamo andare.
Buona lettura.
Dank Politics
→ a cura di Francesco Pirri
L’assurdo può essere distopico? Se due anni fa aveste pensato a quali sarebbero stati gli impatti dell’intelligenza artificiale sulla comunicazione politica, avreste pensato a foto ritoccate per assomigliare ai disegni di Miyazaki, alla trasformazione di crimini contro l’umanità in meme, o a video pubblicati dalla figura politica più rilevante al mondo che mostrano un territorio devastato dalla guerra trasformato nella nuova Dubai?
La trasformazione generata dalle intelligenze artificiali nel mondo della comunicazione, della politica e della cultura è radicale, disordinata, difficile da comprendere. Nutre la cultura dello shitposting attraverso nuovi personaggi, storie e contenuti (vedi il lore dell’italian brainrot, una nuova tappa nell'evoluzione della cultura “dank memes”), diluisce il dibattito nell'immensità dei contenuti prodotti e offre nuovi strumenti di propaganda a chi riesce ad appropriarsi dei nuovi codici di comunicazione. Anche senza IA, il mondo dei nuovi influencer condiziona l’opinione pubblica e ispira nuove pratiche, come il podcast lanciato da Gavin Newsom in America — o i contenuti social di Roberto Gualtieri, mi viene voglia di aggiungere.
Paradossalmente, questa trasformazione sembra indirizzarsi piuttosto verso l’assurdità che verso uno scenario orwelliano di distopia autoritaria davanti al quale avremmo bisogno di sviluppare delle “tecnologie di sopravvivenza”. L’assurdo produce una situazione estremamente volatile, ma nella quale gli equilibri di potere possono vacillare. È pur vero che le grandi aziende tech stanno accumulando un potere sproporzionato in termini economici, politici (in particolare negli Stati Uniti, dove Elon Musk e i suoi “tirapiedi” si stanno appropriando della struttura amministrativa americana) e culturali (per esempio attraverso la capacità di definire loro stessi i rischi della tecnologia che stanno sviluppando). Ma allo stesso tempo, come scrive Naomi Klein citata da Mafe de Baggis, il sistema che si sta dissolvendo era a sua volta “un edificio cucito insieme da negazione e rifiuto, dal non vedere e non sapere, con specchi e ombre. [...] Ora, tra le macerie, possiamo fare qualcosa di più affidabile, più degno della nostra fiducia, più in grado di sopravvivere agli shock in arrivo”.
Fonti: Read Max, Slow Factory, Tlon, Fabian Mosele, Joshua Citarella, Marco De Rossi, Leonardo Bianchi, Indiscreto
Corpevoli
→ a cura di Davide Agazzi
Più le nostre vite si digitalizzano, più tornano a contare i nostri corpi. Cambiano però i canoni di bellezza a cui facciamo riferimento (un pezzo di mondo archivia le forme rotonde, grazie ad Ozempic inseguire il mito della magrezza sembra essere più facile). E, dopo decenni in cui siamo parsi ossessionati dalla cura del nostro corpo, qualcuno torna a pensare che tutto sommato qualche vizio faremmo bene a concedercelo (c’è chi prevede un ritorno di fiamma dei fumatori, chissà!)
Ci sentiamo sempre più padroni dei nostri corpi, tanto da decidere quando farne a meno per sempre (ha scelto il suicidio assistito anche Daniel Kahneman, che ha vinto il Premio Nobel dopo una vita dedicata studiare come gli esseri umani prendono le decisioni).
L’intelligenza artificiale mescola le carte anche in questo ambito, e proprio rispetto alla professione in cui i corpi e la loro unicità contavano più di tutto - fare il modello o la modella. Cosa succede se sono proprio loro però ad autorizzare la creazione di repliche digitali dei propri corpi, creando degli avatar virtuali capaci di resistere alla prova del tempo?
Fonti: RivistaStudio, Read Max, The Wall Street Journal, Business of Fashion
Rewind
→ a cura di Valentina Lunardi
Il 46% dei Gen Z britannici accetterebbe volentieri di essere “severed”, cioè di compartimentare in due spazi diversi e divisi memorie lavorative e personali. Il concetto arriva dalla serie tv già cult “Severance” e la dice lunga sul senso di sopraffazione lavorativa che in molti vivono nell’attuale contesto tardo-capitalista. Anche perché sempre più certezze si sgretolano e il paradigma di ambire a un sicuro “knowledge work” viene messo in discussione dall’IA.
Il lavoro del futuro quale sarebbe quindi? Forse quello che le macchine fanno peggio, cioè creare relazioni, comunità, relazioni. E c’è chi, a dispetto di una “bro culture” imperante, teorizza addirittura la tenerezza come una risposta all’accelerazionanismo tecnologico e capitalistico in cui siamo immersi.
Un segnale è chiaro: nell’epoca della frammentazione e dell’incertezza le persone tornano a cercare connessione umana e rifugio in cerchie ristrette: una generazione di ventenni, infatti, invece di emanciparsi dal nido genitoriale, sta disegnando, soprattutto per il mondo anglosassone, nuove dinamiche di intimità familiare. E se tornare a casa dai tuoi fosse addirittura una chiave per il successo?
Nel frattempo sul fronte genitoriale aumenta lo stress parentale, in particolare legato alla relazione di giovani e bambini con i social media: e se, entro i 2 anni, 4 bambini su 10 possiedono un tablet, cresce la paura tra i genitori su impatti mentali e interazioni con contenuti inappropriati.
Questo orizzonte complesso, fatto di segnali controintuitivi e desiderio di protezione e semplicità, trova forse la sua migliore definizione nel concetto di "regressive nostalgia”. Una tentazione di rimpianto del passato che non vuole affrontare la complessità del presente né immaginare un futuro migliore, ma solo tornare indietro — fondandosi su una visione distorta e semplificata di “quando si stava meglio”.
Fonti: Dazed, Thomas Klaffke, Spike Art Magazine, Dan Salkey, Macleans, The Guardian, Common Sense, What’s Anu
Attorno
→ a cura di Stefano Daelli
Quartiere grigio, futuro grigissimo
Marissa J. Lang e John D. Harden hanno scoperto che i colori preferiti dai nuovi residenti benestanti dei quartieri di Washington sono bianco, nero e grigio, con insegne in metallo e scritte sans serif. Sarebbe il loro segnale in codice per dire: qui è tutto calmo, tranquillo, pulito. E così, i vecchi residenti devono spostarsi un po’ più in là. Perché allora le composizioni dei quartieri cambiano? È quello che il Politecnico di Milano sta studiando: nella mobilità residenziale delle famiglie nelle aree urbane di Milano e Roma, e nei suoi effetti su diversità, disuguaglianza e segregazione delle comunità straniere.
Così, il contesto intorno a noi si fa sempre più ostile. Perché, nel frattempo, se chiudono bar, negozi, etc., per convertirsi in Airbnb o micro-centri logistici, spariscono i posti “dove stare” — magari senza pagare. Ed ecco che monta una gran voglia di nuovi luoghi. C’è chi ha iniziato a chiamarli “quarti luoghi”.
La morte è il tabù del capitalismo
C’è chi, come Sarah Jutras, pensa che dovremmo progettare gli spazi pubblici tenendo in mente la morte come un passaggio naturale da celebrare, non da nascondere — a partire dagli ospedali. Questo si inserisce in un filone di pensiero secondo cui la crisi dell’Occidente è conseguenza del suo stesso successo nell’aver rimosso la morte, a favore dell’assioma che una crescita infinita non solo è possibile ma è un diritto. Così iniziano ad arrivare i primi dispacci che dicono che il prossimo secolo sarà tutto cinese, e non c’è “dinamismo americano” o “resilienza europea” che tenga. Finché non nascerà una nuova sinistra, resteremo nel circolo vizioso attuale. Intanto, ci aspetta un giro su una giostra capitalista sempre più autoritaria.
Se Internet è un posto morto, cambiamolo, o cerchiamo meglio
A volte però mi dico che questo mio pessimismo teleologico dipende dal fatto che sono “cronicamente online”, come si dice ora tra quelli consapevoli di esserlo. Soluzione: meno smartphone, più buonumore. Ma uno studio sui teenager non ha trovato evidenze certe che le politiche scolastiche restrittive migliorino il loro benessere mentale. Forse allora il problema sono i “posti online” che frequento, tutti ottimizzati per tirare fuori il peggio dalle persone (e da me). Da qui, lo studio di piattaforme che incoraggiano comportamenti «prosociali» creando nuove comunità, abilitando il problem-solving collettivo e ampliando i confini della filantropia. Per cominciare, c’è questa lista di siti web e luoghi digitali che “riaccendono sentimenti di gioia, entusiasmo e curiosità” curata da Matthew Prebeg.
Fonti: Freelance (for) Life, Matthew Prebeg, Medusa, Nature, Politecnico di Milano, Protein, The Lancet, Unruly Futures, The Washington Post.
Miscellanea
→ a cura di Luisa Facchinetti
Chi crea, comanda. E se invece di predire il futuro dell’IA ci impegnassimo a crearlo?
Comunità musicali. Analizzando Spotify possiamo vedere come le nostre canzoni preferite ci connettono al resto del mondo in modi inaspettati.
Amsterdam e suoi adesivi. In una continua lotta per farsi strada nello spazio pubblico, commercianti, artisti e attivisti olandesi usano degli stickers per dire “Ci sono, esisto”.
Siamo miliardi, ma quanti? Secondo alcuni ricercatori la Terra è più affollata di quanto pensiamo.
Esoterismo a Torino. Mentre le chiese si svuotano, i piemontesi si rivolgono sempre di più ai cartomanti, creando un giro d’affari da 50 milioni.
Giustizia digitale. Una piattaforma irlandese sta combattendo con l’AI il revenge porn, contenuti piratati e violazione della privacy.
Fonti: Saffron Huang, Lorenzo Gessner Voltolina, Pop Up Cities, NewScientist, Corriere Torino, Ceartas
Segnali dal Futuro è un progetto collettivo che intercetta e racconta storie, sperimentazioni e innovazioni sociali, culturali, tecnologiche, politiche ed economiche.
Nasce da un esperimento dei fondatori di FROM che continua a sostenerla.
Questo numero è curato da Ilaria Nicoletta Brambilla.
Hanno contribuito: Davide Agazzi, Giulio Bordonaro, Ilaria Nicoletta Brambilla, Matteo Brambilla, Mafe de Baggis, Mario Bochicchio, Stefano Daelli, Giorgio De Ambrogio, Cinzia D'Emidio, Luisa Facchinetti, Nicoletta Gomboli, Chiara Leonardi, Valentina Lunardi, Luca Monti, Francesco Pirri, Filippo Pretolani, Silvia Spinelli e Giulio Zucchini.
Identità visiva di This is not a DUO.
Grazie per aver letto Segnali Dal Futuro! Iscriviti gratuitamente per ricevere nuovi post e per supportare il nostro lavoro.